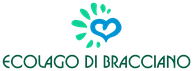L’umanesimo contadino ed antifascista di una famiglia emiliana, il mito dei fratelli Cervi.
Se non fosse stato per la rappresaglia avventatamente decisa dai gerarchi della Repubblica Sociale Italiana, la storia dei fratelli Cervi non sarebbe diventata il mito che è oggi. Sarebbe stata ascritta per lo più alle pagine della Resistenza emiliana o di quelle di una certa cerchia contadina illuminata e votata all’innovazione nei campi. Fucilare in un sol colpo sette fratelli che non si erano resi colpevoli di atti efferati probabilmente sembrò una enormità anche a Benito Mussolini. E’ il 28 dicembre del 1943 quando al poligono di tiro di Reggio Emilia vengono passati per le armi i sette fratelli Cervi. Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. Tutti gli uomini della famiglia Cervi erano stati arrestati il 25 novembre 1943 assieme al padre Alcide e a Quarto Camurri, Dante Castellucci, il russo Anatolij Tarassov, i sudafricani John David Bastiranse, John Peter De Freitas e l’irlandese Samuel Boone Conley, nel proprio cascinale, dopo un intesso conflitto a fuoco. Proprio su questo podere a Campirossi di Campegine a Reggio Emilia la famiglia Cervi aveva scommesso tutto, dopo la decisione di sottrarsi ai vincoli della mezzadria, e di divenire affittuari. Sul campo i Cervi sperimentano ed innovano. Utilissimi diventano le letture di tecnica agraria che Aldo compie. Aldo durante la leva aveva ferito un sergente ed era stato in carcere due anni, conoscendo molti detenuti anti regime e sviluppando una coscienza politica. Il livellamento del terreno con la realizzazione di canali di scolo ai quali i sette fratelli si dedicano è un’esperienza pilota che in futuro è replicata in tutta la zona. I Cervi sono al passo coi tempi. Vicini alle idee socialiste e di Cesare Prampolini e Labriola i Cervi vanno via via costituendo nella loro casa anche un primo importante nucleo di resistenza antifascista. Sono contadini partigiani. Il loro cascinale (oggi casa museo) diviene un vero e proprio laboratorio politico, una sorta di cellula dell’Internazionale, qui trovano rifugio perseguitati politici di varie nazionalità. “Capimmo che il socialismo eravamo noi e che anche noi eravamo un po’ l’Unione Sovietica” ebbe a dire il padre. Suo padre Agostino era stato uno dei capi della rivolta contro la famigerata tassa sul macinato del 1869 ed era stato in carcere per sei mesi. Campi e politica antifascista, questo il pane quotidiano della numerosa famiglia Cervi fino al giorno dell’arresto. I sette fratelli ed il padre finiscono nella stessa cella. Il 27 dicembre viene ucciso il camerata Davide Onfiani, segretario comunale, presso Bagnolo in Piano. Un “tribunale speciale” riunito in tutta fretta nella notte fa scattare la rappresaglia. Vengono scelti i sette fratelli Cervi. I fratelli sanno di andare a morire ma al padre, salutandolo per l’ultima volta, nascondono tutto. L’esecuzione, senza un regolare processo, avviene all’alba al poligono di tiro di Reggio Emilia. Cade sotto i colpi del plotone anche il compagno di lotta Quarto Camurri. Quando gli alleati nel 1944 bombardano il carcere dove è detenuto a San Tommaso, papà Alcide trova la via di fuga e torna alla sua casa a Campirossi. Qui apprende della morte dei suoi ragazzi. Si rimbocca le maniche e con le due figlie femmine, Rina e Diomira, e le vedove dei figli riprende a coltivare i campi. Ma la mamma Genoeffa non ce la fa a sopportare un dolore così grande. Muore, si può certamente dire, di crepacuore nel novembre del 1944. Solo due anni dopo dalla morte, le salme dei sette fratelli troveranno una degna sepoltura nel campo santo di Campegine. La storia dei fratelli Cervi si fa mito. Salvatore Quasimodo gli scrive un componimento. Così gli ultimi versi: Scrivo ai fratelli Cervi/non alle sette stelle dell’Orsa: ai sette emiliani/dei campi. Avevano nel cuore pochi libri,/morirono tirando dadi d’amore nel silenzio./Non sapevano soldati filosofi poeti/di questo umanesimo di razza contadina./L’amore la morte in una fossa di nebbia appena fonda./Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore,/non per memoria, ma per i giorni che strisciano/tardi di storia, rapidi di macchine di sangue. Luigi Einaudi, autore di alcuni dei testi agrari sui quali Aldo Cervi studiava, fa visita a papà Alcide. Il film I Sette fratelli Cervi (1967) di Gianni Puccini interpretato tra gli altri da Gian Maria Volonté traduce in immagini la loro vicenda. Il partito comunista invia un proprio intellettuale comunista, il comunicatore Renato Nicolai, che insieme ad Alcide realizza un’autobiografia. Ed è da questa pagine, dal racconto semplice e ispirato di Alcide, che traspare chiara la fedeltà al socialismo, per una società migliore. “L’unico modo per non avere padroni cattivi e quella di non avere padroni”. “Dove adesso c’è verde, prima era acqua stagna e miseria”. Ma l’immagine simbolo ricordata da Alcide resta certo quella del seme. “Mi hanno detto sempre così. Tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami, quelli sono stati falciati è la quercia non è morta. Va bene… la figura è bella e qualche volta piango nelle commemorazioni…ma guardate il seme, perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia guardate il seme…il nostro seme è l’ideale nella testa dell’uomo”.
Questa è la storia dei sette fratelli Cervi.
Articolo già pubblicato su Gente di Bracciano.