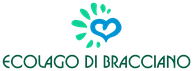Venerdì 4 aprile, la Sala delle Assemblee di Palazzo Brugiotti, a Viterbo, ha fatto da cornice alla presentazione dello spot e delle iniziative dedicate alla figura di Alessandro Farnese, divenuto papa Paolo III, voluti dal Comune di Canino e organizzati dalla ST Sinergie con il patrocinio della Fondazione Carivit e dell’associazione Rievocazioni Storiche del Lazio e il sostegno di numerosi sponsor locali.
A fare gli onori di casa, il presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti, che ha rimarcato il richiamo storico della manifestazione: “Supportiamo questo progetto soprattutto perché la fondazione ha a cuore da sempre le iniziative che mirano a valorizzare e veicolare la storia del territorio. In quest’ottica vorremmo realizzare, forse per l’anno prossimo, una mostra sulla distruzione della Città di Castro, avvenuta nel 1649, basandoci sui dettagli riportati da un testo conservato nella Biblioteca Consorziale di Viterbo e coinvolgendo tutti i Comuni di quell’area”.
“Siamo onorati di essere in questa prestigiosa sede per presentare un prestigioso progetto” ha proseguito Tiziana Lagrimino, responsabile organizzativo della ST Sinergie . “Oltretutto – ha aggiunto – documentandomi, ho scoperto che proprio questa strada, via Cavour, in passato si chiamava via Farnesiana ed era stata voluta dalla famiglia Farnese per migliorare il percorso da Roma a Viterbo. Lo spot accompagnerà i numerosi eventi che verranno realizzati a Canino durante questo Anno Santo con l’obiettivo di far crescere la cittadina sia da un punto di vista culturale sia, di riflesso, turistico ed economico”.
Il video, diretto e sceneggiato dal regista bomarzese Giovanni Proietti e realizzato da Sigfrido Hobel Junior di Project Tuscia, in circa due minuti sintetizza il vissuto di Alessandro Farnese, a cui Canino diede i natali il 28 febbraio del 1468 e che morì come Paolo III a Roma il 10 novembre del 1549, evidenziando il forte legame con l’incantevole paese della Tuscia, al punto da definire: “La pace di questo luogo un balsamo per l’anima e il corpo”.
“Nel Giubileo non potevamo non celebrare la figura di un papa che ha lasciato il segno nella storia della Chiesa Cattolica”, ha sottolineato il sindaco Giuseppe Cesetti . “Diventato cardinale grazie alla sorella Giulia, che è stata degnamente ricordata nell’anno appena concluso per i 500 della morte – ha aggiunto Cesetti – è un personaggio che ha dato un’impronta indelebile nel nostro borgo e in molte zone della provincia. L’idea è di far conoscere Canino, famosa per l’olio ottimo e la Sagra dell’Asparago Verde, anche per una storia così significativa”.
Denso il calendario di iniziative che fino al termine del 2025 animerà Canino: dal “Giubileo dei Fiori” con installazioni floreali nel centro storico con intermezzi di performance a cura dell’associazione culturale Paolo III Farnese e sfilate di Gruppi Storici, all’educational rivolta alla scuola primaria e secondaria di Canino curata dalla Presidente dell’AC Paolo III Farnese, Laura Ruzzi che vedrà gli studenti protagonisti anche della visita didattica ai Musei Capitolini e alla
mostra “I Farnese nella Roma del Cinquecento”, fino alla realizzazione di un vino e un olio pensati ad hoc per Papa Paolo III e, in conclusione, un Convegno di studi curato dal professor Paolo Procaccioli e dal dottor Andrea Alessi, fissato per il 29 novembre, che sarà un’occasione di riflessione e ricerca sulla figura di Alessandro Farnese/Paolo III per ricollocarlo dentro il proprio tempo.
Da segnare in agenda anche l’appuntamento previsto per sabato 5 aprile, alle ore 17.30, presso il Palazzo dell’Arancera – “strada dell’Olio”, in corso Giacomo Matteotti 13, a Canino, dove verrà proiettato di nuovo lo spot promozionale a beneficio della comunità locale e verrà svelato per la prima volta in assoluto il logo della manifestazione, realizzato da Bruno Morroto.


Papa Paolo III Farnese
(Canino, 28 feb. 1468 – Roma, 10 nov. 1549)
Alessandro Farnese, secondogenito di Pier Luigi e di Giovannella Caetani, figlia di Onorato III duca di Sermoneta, nacque a Canino il 28 febbraio 1468. La madre apparteneva all’antico baronaggio che aveva dato alla Chiesa un papa, Bonifacio VIII, e sei cardinali; il padre discendeva da una famiglia nobile di media grandezza originaria del Lazio settentrionale, dove fin dal Duecento possedeva alcuni castelli e che acquistò rilevanza politica e sociale grazie al valore militare di molti suoi membri al soldo dello Stato pontificio e di Firenze.
Nel 1450 il nonno di Alessandro, Ranuccio il Vecchio, definiva il casato «magnifica domus de Farnesio» e lasciava
agli eredi numerose terre sulla riva occidentale del lago di Bolsena.
Tuttavia, nell’educazione di Farnese, sulle tradizioni militari paterne prevalsero le relazioni curiali dei Caetani, che lo orientarono verso la carriera ecclesiastica. Avviato agli studi umanistici da Stefano dell’Aquila e Pomponio Leto e designato da papa Sisto IV (4 febbraio 1482) scrittore apostolico, dovette interromperli per motivi non chiari, ma verosimilmente legati al conflitto tra il nuovo pontefice, Innocenzo VIII, e Ferrante d’Aragona (1485-86), cui il fratello Angelo prese parte al soldo di Lorenzo il Magnifico, schierato contro il papa. Tenuto in ostaggio a Castel Sant’Angelo, ne evase il 25 maggio 1486, trasferendosi nell’estate a Firenze, accolto dalla sorella Gerolama, moglie di Puccio Pucci, intimo di Lorenzo.
Introdotto nella cerchia di illustri umanisti di cui questi si circondava, poté approfondire con Demetrio Calcondila la conoscenza del greco. In seguito alla riappacificazione tra Innocenzo VIII e il Magnifico, sigillata dal matrimonio della
figlia di quest’ultimo con Franceschetto Cibo (1487), figlio naturale del papa, e dal cardinalato al figlio Giovanni (9 marzo 1489), futuro papa Leone X, Lorenzo, tramite il suo ambasciatore a Roma Giovanni Lanfredini, raccomandò il Farnese al papa.
Dopo aver ottenuto il titolo di cardinale nel 1493, Alessandro si affermò come abile politico ecclesiastico, ricoprendo vari incarichi di rilievo.
Uomo di vivo ingegno e di larga cultura, attinta in massima parte nella Firenze del Rinascimento, dovette l’elezione alla sua indipendenza rispetto alle due potenze che allora si contendevano il predominio, Francia e Impero, che poi come
pontefice (dal 1534) si sforzò di conciliare. Il primo frutto della sua politica di neutralità tra Francia e Impero fu la conclusione della tregua di Nizza (1538); opera sua, benché fosse escluso dalla conclusione, fu la successiva pace di
Crépy (1544). I rapporti con gli altri Stati europei e italiani furono in funzione della politica generale di pacificazione e neutralità e dell’indirizzo di riforma e di reazione contro il protestantesimo impresso al pontificato.
Fulcro dell’attività di pontefice fu l’avvio della Controriforma, che si concretizzò con una serie di colloqui convocati, inizialmente con intento conciliativo rispetto alle posizioni protestanti, già all’indomani della sua elezione al soglio pontificio, che culminarono però con un’aperta presa di posizione contro il Protestantesimo nel Concilio di Trento (1545-1563) e con la riorganizzazione dell’Inquisizione, accompagnata il 21 luglio 1542 dalla bolla Licet ab initio. Circondatosi di cardinali particolarmente attivi e impegnati in tal senso, riconobbe nel 1540 la Compagnia
di Gesù fondata da Ignazio di Loyola.
Di pari passo con il concilio doveva procedere la riforma interna della Chiesa, che Paolo III agevolò creando cardinali a essa favorevoli, come Contarini, Carafa, Pole, Morone e Sadoleto.
Fu inoltre grande mecenate, incline al nepotismo. Il suo pontificato è caratterizzato da un forte impegno nella promozione delle arti e della cultura. Paolo III sostenne artisti di fama come Michelangelo, contribuendo alla realizzazione di opere significative, tra cui la decorazione della Cappella Sistina.
Nel contempo illustri artisti richiamati a Roma dal suo mecenatismo eseguivano splendidi ritratti dei Farnese – celebri quelli di Tiziano – e altri, tra i quali Prospero Fontana, Pellegrino Tibaldi, Perin del Vaga, Girolamo Siciolante, esaltavano negli imponenti cicli pittorici degli appartamenti papali di Castel Sant’Angelo le imprese e le virtù del pontefice e le gesta dei suoi avi. Ai complessi programmi iconografici, densi di significati ideologici e simbolici che sottendevano i grandi affreschi, collaborarono umanisti e letterati, attratti a Roma dalle ricompense e dai
riconoscimenti concessi dai Farnese ai cultori delle humanae litterae.
In questo progetto di renovatio Urbis – che culminò nella riqualificazione del Campidoglio a opera di Michelangelo e nella costruzione di una residenza estiva sul colle capitolino attigua al palazzo dei Conservatori – Paolo III, da dotto
umanista, volle certamente esaltare il mito della continuità del papato con la Roma imperiale, ma anche accattivarsi la benevolenza e la fedeltà del ceto municipale, da lui gratificato con uffici, benefici, cappelli cardinalizi.
Papa Paolo III morì il 10 novembre 1549, lasciando un’eredità complessa. La sua figura è spesso vista come un simbolo della transizione tra il Rinascimento e la Controriforma, rappresentando un periodo di rinnovamento e sfide per la Chiesa cattolica. La sua influenza si estese oltre il suo pontificato, contribuendo a plasmare il futuro della Chiesa e della società europea.
Nota biografica a cura di Andrea Alessi